“Forse”: perché i figli la chiamavano mamma, i nipoti la chiamavano babuška, e quindi non è del tutto sicura che si chiamasse Esther la bisnonna finita tra i massacrati di Babi Yar.
Anche questa, come Gli scomparsi e Konin, è la storia di una ricerca: ricerca delle proprie radici, ricerca delle tracce di chi non c’è più. Ricerca i cui esiti dipendono dalla tenacia impiegata, e un po’ anche dal destino. Che a volte si presenta del tutto casualmente, e vi si inciampa sopra.
Durante il mio viaggio del 1989 in Polonia visitai anche Varsavia, la città in cui mia nonna Rosa era nata nel 1905, quando il paese apparteneva ancora alla Russia. […]
Così vagabondai per quella città dalla storia ricostruita ex novo e, non lontano dal monumento a Chopin, mi comprai un disco solo perché, nel vederlo, ne ero rimasta sorpresa. Sulla copertina campeggiava infatti un mogendovid, una stella di Davide. Non era passato molto tempo da quando avevo udito per la prima volta la parola mogendovid, a significare la stella a sei punte. Sul disco c’era scritto qualcosa come Żydowskie piosenki wshodniej Europy. Allora trascrissi in russo quelle parole polacche, e adesso le traduco in tedesco, Jüdische Lieder aus Osteuropa, Canti ebraici dall’Europa orientale. Il mogendovid si stirava e allungava sulla copertina, con la stessa naturalezza con cui il nostro paese si estendeva dall’Europa al Pacifico. Lo osservavo come fosse un animale sconosciuto, pronto a muoversi da un momento all’altro, saggiavo ciascuna delle sei punte, seguivo ogni rotazione, ogni angolo. Per tutta la vita avevamo dipinto stelle a cinque punte, quelle che brillavano sulla terra e quelle che brillavano in cielo, le stelle del nostro Cremlino, che eravamo soliti celebrare con un inno, e c’era poi anche quella canzone in cui una stella parla con un’altra stella, la intonavamo quando ci toccava fare la strada da soli – ma nessuna di esse aveva sei punte. Mai prima di allora mi era accaduto di incontrare nella mia patria tanto estesa un mogendovid, né come simbolo né come oggetto.
La stella a sei punte mi aveva stupita, non perché fossi sempre stata ansiosa di vedere un mogendovid, non sapevo nemmeno che si potesse desiderare una cosa simile, il desiderio era defraudato del suo contenuto, divelto con tutte le radici, così come il contenuto delle stanze in quelle case abbandonate. Ero confusa per la sorpresa provata alla vista del mogendovid accuratamente dipinto in blu scuro su fondo bianco, con una colomba colorata nel mezzo.
Di ritorno a Kiev misi il disco sul piatto del grammofono, e mia nonna, che aveva da sempre un leggero accento polacco – ricordo la parolina cacki, un termine di origine polacca per dire «gioielli», usato da Rosa per le mie carabattole, gli oggetti inutili, cacki, come un lecca lecca, un ledenets dalla ts aspra -, mia nonna che, a memoria di mia madre e mia, non aveva mai pronunciato una sola parola in yiddish, si mise d’un tratto a intonare canti baldanzosi in una tonalità minore e vagabonda, dapprima seguendo le parole del disco, andandovi dietro, poi all’unisono e senza incertezze, infine anticipandole di colpo con precipitosa letizia, e io la ascoltavo con la medesima incredulità con cui avevo saggiato il mogendovid sulla custodia del disco. Senza la Perestrojka, senza il mio viaggio in Polonia, senza quel disco, la finestra sigillata della sua lontana infanzia non si sarebbe mai più dischiusa per noi, e io non avrei mai capito che la mia babuška veniva da una Varsavia ormai inesistente, che di lì noi veniamo, mi piaccia o meno, da quel mondo perduto di cui mia nonna si ricordò all’ultimo, sul limitare, mentre già stava per lasciarci, per prendere da noi congedo.
Come sorpreso nel rimemorare, il tempo si dilatò e agguantò Rosa; attraverso il disco giunse a me, e in lei destò ricordi, che – così sembrava – erano del tutto ammutoliti e sepolti, al pari di quella che doveva essere stata un tempo la sua lingua materna: l’idioma da noi e da lei stessa ormai dimenticato.
Altre volte, invece, come in una sinfonia di Beethoven, bussa prepotentemente alla porta.
Quella volta suonò il telefono. Era la notte di San Silvestro del 2011 a Kiev. Mia madre andò a rispondere.
Mi chiamo Dina, disse una vecchia signora, ho sentito che lei sta raccogliendo informazioni sulla scuola numero 77 di Kiev, nel 1940 io mi sono diplomata presso quella scuola. Telefono da Gerusalemme.
Era da un pezzo che il 1940 non ci mandava più segnali, di lì giungeva un vento freddo, come una telefonata che arrivasse direttamente dall’Aldilà: la riprova ne era Gerusalemme, una tappa intermedia. Mia madre se ne stava impietrita con il ricevitore in mano e riuscì a dire soltanto, con voce rauca ma ferma: Sì, la ascolto.
Il telefono fu messo in viva voce.
Gli ospiti di Capodanno fecero silenzio.
Abbiamo lasciato Kiev allo scoppiò della guerra, disse Dina in tono deciso. Fummo evacuati nel Dagestan. Di lì emigrammo in Israele negli anni Settanta, io non sono mai più tornata a Kiev. Ho appena ritrovato su facebook una delle mie compagne che frequentò con me l’ultimo anno di scuola, nel 1940. Mi ha detto che lei ci stava cercando. Sì, ho ottantotto anni, con il computer me la cavo, mi aiuta mia figlia. Lei è archivista?
No, sono insegnante di storia, rispose mia madre e raccontò che lavorava in quella scuola da quarant’anni e adesso stava cercando si ricostruirne la storia, anche se io direi piuttosto che mia madre stava reinventando la storia della scuola. Parecchio tempo fa, disse, ho messo in scena con i miei allievi una pièce sulla classe che diede l’esame di maturità nel 1941 e che, il giorno dopo il ballo finale – il primo giorno di guerra -, venne mandata direttamente al fronte: avevamo trovato alcuni compagni e li abbiamo portati sul palcoscenico.
Anziché rispondere, Dina elencò i nomi dell’intera classe, poi di tutti gli insegnanti e infine di alcuni genitori.
Non ne aveva dimenticato uno, a settant’anni dal giorno del diploma.
Dopo la guerra, quando i sopravvissuti rientrarono lentamente a Kiev dal fronte o dai luoghi di sfollamento, nessuno sapeva nulla di Dina. Un quarto della classe era caduto in guerra, e a un certo punto le ricerche s’interruppero. Dina era ebrea, e poteva essere finita a Babij ]ar, ingoiata da quella forra o da qualche altra fossa comune. A volte non si cercava perché si era sicuri. Dina invece era viva.
Dove abitava a Kiev, domandò mia madre.
Non lontano dalla scuola, nella Institutskaja.
Nell’udire il nome di quella strada mia madre si agitò.
Dove esattamente?
All’angolo con via Karl Liebknecht.
Nella casa grigia, lì all’angolo? Di fronte alla farmacia?
Sì, disse Dina, il primo ingresso a sinistra.
Ma anche noi abitavamo lì, gridò mia madre.
Ma non c’erano Petrovskij nel nostro caseggiato, rispose Dina.
Ma io mi chiamo Ovdijenko!
Svetočka! esclamò allora Dina.
I presenti tacquero tutti, come sapessero benissimo di che cosa si trattava. Mio padre fu il primo a lasciarsi sfuggire un breve singhiozzo. Qualcuno aveva appena chiamato mia madre, un’adulta, con il nome che aveva da bambina. Non c’era più nessuno, ormai, di quella generazione.
Dina era stata realmente una vicina di casa di mia madre, e aveva tredici anni più di Svetočka. Si ricordava di ogni mio famigliare e di altri vicini ancora, che avevano abitato in quella casa prima della guerra.
Terminato il lungo elenco di nomi, disse: Grazie, Svetočka.
Grazie di cosa? domandò Svetočka.
Dina ringraziava settant’anni dopo perché mia nonna Rosa, allora direttrice della scuola per sordomuti, le aveva affidato i suoi allievi, quando lei stava cercando lavoro. Così quella si era trasformata nella professione della sua vita: dopo la guerra Dina divenne insegnante per non udenti, come in seguito sua figlia, dapprima nel Dagestan e poi in Israele e anche i figli di sua figlia divennero insegnanti per non udenti e logopedisti, così come alcuni nipoti. Grazie a voi, Svetočka.
Dina disse poi che ricordava quando, nel 1939, era morto il mio bisnonno Ozjel Krzevin. L’ho sentito cadere a terra e sono corsa su, era d’autunno. Io avevo quattro anni, precisò mia madre, e ricordo ancora che gli adulti erano sconcertati perché avevo detto: Lasciatelo stare, è stanco. E Dina confermò: È vero. Hai detto proprio così!
E per fortuna, per la fortuna di tutti noi, ci sono di queste persone dalla volontà implacabile, dalla determinazione indomabile a ritrovare le proprie radici, quelle radici che, a volte, neppure si sospettava di avere. Regalandole, una volta trovate, non solo a se stessi ma anche a tutti noi.

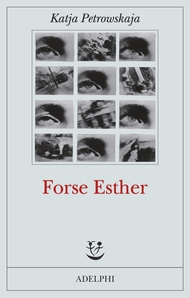
Naturalmente quando la zia e io abbiamo letto questo articolo, non potevamo non essere commossi. Più lei, però. Ecco il suo breve racconto: Perché quando mia nonna prima di morire mi aveva detto che era Ebrea e che non lo sapeva nessuno, le ho accarezzato i capelli bianchi e le ha sussurrato: “Grazie, nonna per avermi detto la verità. Sei sicura, nonna?”
“Sì, figgia mia” (parlava dialetto calabrese) e scendono le lacrime e le spiega che lo sapeva da sua madre, e dalla madre di sua madre ma avevano paura di dire che erano Ebrei.
Da allora, la zia non si dà pace per trovare le sue radici, naturalmente aspramente osteggiata da sua mamma (mia nonna) che anche se sapeva già, dice che a lei va bene essere italiana, non ebrea. (nessun di noi la critica, perché è anziana anche se la zia le tiene testa nelle discussioni) .In primavera zia Vittoria andrà in Calabria, a Melito Porto Salvo, per trovare i certificati di nascita materni e spera di arrivare fino alla genealogia completa.
Sarà un duro lavoro, e forse, dato che siamo in Italia, non sarà nemmeno certo che ce la farà ad approdare a nulla di concreto.
Ma una cosa è certa questa mattina: ordineremo in libreria sotto casa il libro “Forse Esther”.
Stragrazie, Barbara che proponi sempre argomenti nuovi, così pieni di emozioni e ti spingono a crescere nell’animo. A guardarti dentro. Almeno, per quanto riguarda noi.
Con rispetto e gratitudine, Samuele
"Mi piace""Mi piace"
Dovreste rivolgervi al rabbino di Napoli, che è responsabile per tutto il sud Italia: forse lui saprà come aiutarvi a indirizzare le ricerche.
"Mi piace""Mi piace"
Sì, è vero. Ce lo ha detto anche la signora Emy di Milano, l’altro giorno.
E anche il rabbino che c’è in piazza castello.
Grazie, Barbara. Samuele
"Mi piace""Mi piace"
Anch’io lo comprerò.
"Mi piace""Mi piace"
Merita davvero.
"Mi piace""Mi piace"
La mia lista si allunga… grazie cara amica!
E dire che son stata ‘accusata’ 🙂 di aver ‘une mine juive’ da amici carissimi in Canada – appunto di origine giudea… inoltre, la mia nonna paterna assomigliava tantissimo – forse un po’ più addolcita – alla grande Golda Meir…
Chissà che quel cordone ombelicale che non mi sembra sia mai stato tagliato sia proprio …
"Mi piace""Mi piace"
Golda Meir da giovane era molto bella e sensuale
"Mi piace"Piace a 1 persona
Anche mia nonna lo era, mi dicono, non ho sue foto da giovane… io parlavo delle due ormai ‘nonne’, che le mie amiche ebree trovarono veramente somiglianti 🙂
"Mi piace""Mi piace"
Vedrai che alla fine viene fuori che erano anche parenti!
"Mi piace"Piace a 1 persona
😀
"Mi piace""Mi piace"